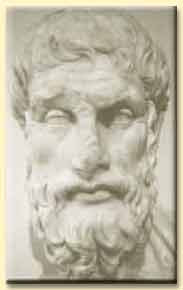|
Ritratto di Epicuro Epicuro (Samo, 341 a.C. - Atene, 270 a.C.) fondò il suo kèpos ("Giardino") in Atene nel 306. Di lui ci restano i seguenti scritti:
Considerazioni preliminari Il pensiero di Epicuro, ancorché profondamente originale, ha le sue premesse nell'ambito della classica opposizione greca phýsis / nòmos: il filosofo prende infatti le mosse da un radicale rifiuto del nòmos o cultura, che gli appare in generale, in tutte le sue manifestazioni, come deprecabile fonte di false opinioni, atte solo a complicare e rendere angosciosa l'esistenza umana (esemplare il caso dell'attività politica): per essere felici e conoscere la verità, occorre liberarsi di queste fallaci sovrastrutture e basare le proprie convinzioni sull'osservazione di ciò che veramente e indubitabilmente è, cioè la phýsis o natura. In particolare, due sono i bersagli di Epicuro in ambito filosofico: gli astratti sistemi logico-matematici cui si è ridotta la speculazione nella seconda metà del IV secolo, soprattutto nell'ambito dell'Accademia e del Perìpato; e il cosiddetto "teleologismo òntico" di Platone e della sua scuola, ovvero la convinzione che tutto ciò che esiste esista per un fine (voluto, naturalmente, da una Mente divina). Il primo atteggiamento risulta di nessuna utilità pratica: e se la filosofia non aiuta l'uomo a vivere meglio, a detta di Epicuro è altrettanto inutile di una medicina che non sappia guarire le malattie. Il secondo ingenera nell'uomo timori ed angosce e lo espone al rischio della manipolazione ideologica, perché sarà facile fargli credere che ciò che gli viene imposto dall'alto sia voluto da Dio. Al contrario, secondo Epicuro, ogni uomo ha il diritto e il dovere di ragionare in modo autonomo, rinnegando ogni condizionamento socio-politico: non tutti, evidentemente, saranno in grado di comprendere ogni dettaglio della verità (a questa ristretta minoranza è dedicato il complesso e tecnicissimo trattato Perì phýseos); l'essenziale del discorso è però alla portata di tutti ed è più che sufficiente per vivere bene (a questo scopo sono destinate le lettere divulgative A Erodoto, A Pìtocle e A Menèceo).
Si suol dire che quello di Epicuro (come quello di Zenone) è uno pseudo-sistema, comprendente in apparenza tutte le branche fondamentali del sapere filosofico (fisica, logica, etica), ma in realtà imperniato sull'etica: in questa prospettiva la fisica e la logica risulterebbero, a detta di molti, elaborate a posteriori per fornire una giustificazione teorica ai princìpi dell'etica, ma non avrebbero una loro intrinseca validità. Molti critici pongono l'accento, ad esempio, sulla "puerilità" della teoria del clinamen, che considerano introdotto nella fisica in modo strumentale alle esigenze dell'etica, ovvero esclusivamente per giustificare l'esistenza del libero arbitrio; anche la logica epicurea viene spesso criticata per le sue presunte aporìe, dovute certo all'obiettiva difficoltà di spiegare come possa realizzarsi il meccanismo complesso del pensiero mediante gli atomi, ma talora imputate a scarso interesse per la teoria della conoscenza. Queste considerazioni appaiono viziate da un equivoco di fondo: occorre tenere presente che noi non conosciamo, di prima mano, che una piccola parte delle opere di Epicuro: troppo spesso assumiamo per certo che le rielaborazioni della sua dottrina compiute dai suoi discepoli (soprattutto Lucrezio) ne mantengano intatto il senso, mentre potrebbero esservi state apportate "correzioni" o potrebbero essersi verificati dei semplici fraintendimenti. Per confutare le critiche sopra citate, ad esempio, basterebbe osservare che, nelle opere a noi conservate di Epicuro, non si parla mai del clinamen, e che fra le opere perdute del Maestro era annoverata una "Canonica", dedicata esclusivamente ai princìpi essenziali ("canoni") della logica. Ma, più in generale, occorre sottolineare con forza che la presunta priorità assegnata da Epicuro all’etica è assolutamente opinabile: ché anzi, a ben guardare, il fondamento primo di tutta la costruzione filosofica del Maestro appare essere piuttosto la fisica, come dovrebbe risultare evidente anche dalla struttura del De rerum natura lucreziano e dalle sue intenzioni polemiche nei confronti della religio tradizionale: per confutare la quale non è affatto essenziale l’etica, che infatti è oggetto di una trattazione alquanto sommaria da parte di Lucrezio, mentre è assolutamente indispensabile la fisica, che, mediante il materialismo atomistico, destituisce di ogni fondamento la fede tradizionale nell'aldilà, nell'immortalità dell'anima e nell'esistenza del Destino. In effetti, poste determinate premesse fisiche che stabiliscono com'è fatto l'universo e com'è fatto l'essere umano, le scelte compiute in sede di etica ne discendono come necessarie conseguenze. Non pare, insomma, che Epicuro si sia orientato verso la teoria atomistica per giustificare le sue convinzioni etiche, ma, al contrario, si direbbe che l'osservazione della Natura lo abbia indotto in primo luogo a fare proprio questo modello interpretativo del reale, e che rispetto a questo, e dunque a posteriori, si siano definite scelte etiche coerenti con tali premesse. Vero è che l’etica è stata considerata in seguito come il momento più alto ed interessante del pensiero epicureo, soprattutto perché in grado di dare una risposta alle diffuse inquietudini spirituali proprie di tanta parte della società ellenistica e romana; ma questo non autorizza ad attribuire ad Epicuro stesso un interesse pressoché esclusivo per l’etica.
A proposito della teoria atomistica, è opportuno osservare subito che Epicuro è largamente debitore di Democrito, anche se, piuttosto sorprendentemente, nega ogni dipendenza dal filosofo ed anzi ne contesta le teorie. Le ragioni di questo atteggiamento di rifiuto risiedono forse nella relativa autonomia di certe asserzioni di Epicuro rispetto all'atomismo democriteo, come si vedrà meglio in seguito.
Fisica Il nulla non è pensabile: ciò che è pensabile è necessariamente corporeo. Ciò che è corporeo si estende necessariamente nello spazio (chòra). Ciò che è corporeo e si estende nello spazio è divisibile, ma non all'infinito: se infatti fosse divisibile all'infinito, si ridurrebbe a zero, cioè al non-pensabile nulla. Poiché, dunque, noi pensiamo la realtà, se ne deduce che essa è corporea, si estende nello spazio ed è divisibile, ma non all'infinito. La trasformazione, che vediamo accadere in natura, è permessa proprio dal fatto che i corpi sono composti di particelle più piccole, ché, se fossero semplici e indivisibili, non potrebbero trasformarsi. Le particelle indivisibili da cui è formata la realtà si chiamano atomi (da alpha privativo + tèmno = "tagliare"). Ecco una prima differenza rispetto a Democrito: questi, infatti, concepiva l'atomo come un ente matematico astratto, un punto geometrico privo di effettiva grandezza fisica, il che lo aveva esposto alle contestazioni di Aristotele; ora, la non-visibilità dell'atomo non significa che esso non abbia una sua consistenza fisica, visibile se non altro agli occhi della mente. Gli atomi sono dunque, per Epicuro, forniti di una loro forma, di una loro grandezza e di un loro peso; non solo: sono anche qualitativamente differenziati, ché, altrimenti, "tutto nascerebbe da tutto", il che non è. Non a caso il termine adottato talvolta da Epicuro per definire l'atomo è "seme" (sperma), evidentemente desunto da Anassàgora (il solo filosofo per il quale Epicuro esprima ammirazione). Ciò che esiste (il reale) è costituito dall'aggregazione degli atomi nello spazio vuoto. Né gli atomi né il vuoto esistono: essi sono (dunque enti, non esistenti). La realtà, cioè, li presuppone, ma essi non sono realtà (non si danno, infatti, nella realtà, né lo spazio vuoto né singoli atomi a sé stanti). Se poi l'atomo, in quanto grandezza fisica, ha un peso specifico, è inevitabile che esso segua una sua direzione nell'infinito spazio vuoto, cioè si muova: per cui le tre condizioni che rendono pensabile il reale sono atomi, vuoto e movimento. Ed ecco una seconda differenza rispetto a Democrito, che coinvolge la spinosa questione del clinamen: se gli atomi, come sostiene Democrito e come postula anche Epicuro, cadono nel vuoto, dall'alto verso il basso, a identica velocità (nello spazio infinito, la velocità non può che essere assoluta), come possono incontrarsi e formare così gli aggregati corporei? Nasce così la teoria della parènklisis (il lucreziano clinamen), che non risale a Democrito: in base a questa teoria gli atomi avrebbero la possibilità di deviare spontaneamente dalla loro traiettoria per incontrare altri atomi e formare così i corpi. Criticatissima e talvolta derisa, questa curiosa teoria fisica pare elaborata, come si diceva, a posteriori, per giustificare in qualche modo l'esistenza del libero arbitrio. Infatti, se tutto accade in base a pure e semplici leggi meccaniche, in assenza di un principio spirituale, come si spiega la capacità dell'uomo di effettuare scelte autonome, varie e contraddittorie?Epicuro, per sua stessa ammissione, aborre il rigido determinismo meccanicistico dei fisici più ancora di quanto detesti le favole della religione tradizionale: nel libero arbitrio crede fermamente e ne giudica incontestabile l'esistenza. Ma, poiché l'uomo è formato di atomi, anche il libero arbitrio non può risalire che agli atomi: bisogna dunque pensare che gli incontri degli atomi (da cui dipendono quelle che chiamiamo scelte) non avvengano in modo meccanico e necessario, ma in maniera, per così dire, spontanea. Tuttavia, come si accennava in precedenza, di questa teoria non vi è traccia in Epicuro: essa viene riportata soltanto dai suoi discepoli (cfr. Lucrezio e Diogene di Enoanda), non si sa con quanta fedeltà rispetto alle teorie del Maestro. Il motivo del clinamen potrebbe comunque essere frutto di una errata interpretazione di un passo - effettivamente oscuro - della Lettera ad Erodoto, in cui Epicuro parla dell'incontro-scontro degli atomi nel vuoto. Sembra infatti di intendere che l'equivoco di base consista nell'immaginare le traiettorie di caduta degli atomi come parallele, quasi che per ciascuno di essi l'alto e il basso si trovassero nel medesimo luogo, mentre Epicuro dice chiaramente che "l'alto e il basso dell'indefinito non si può predicare né come il punto più alto né come il punto più basso" (Lettera ad Erodoto, 60): in altre parole, com'è ovvio, in assenza di punti di riferimento non si può parlare né di alto né di basso in senso assoluto. Quando dunque Epicuro dice che gli atomi cadono dall'alto verso il basso, alluderà evidentemente all'alto ed al basso relativi alla traiettoria di ogni singolo atomo: il che significa che le traiettorie non sono affatto parallele, perché ogni singolo atomo cade verso il suo basso ed interseca le traiettorie degli altri atomi, ciascuno teso verso il suo basso. Così facendo, talvolta gli atomi cozzano gli uni contro gli altri, e rimbalzando deviano dalla loro traiettoria naturale: appunto da questa osservazione di Epicuro, probabilmente fraintesa, potrebbe essere nata la teoria del clinamen. La varietà degli aggregati corporei è dovuta ad originarie differenze tra gli atomi: essi sono infatti, come si diceva, diversi per forma, peso e grandezza, anche se la loro grandezza - sottolinea Epicuro - non può essere "una qualsiasi", come sosteneva Democrito, perché in tal caso avremmo atomi infinitamente piccoli (e dunque l'annullamento degli atomi) ed atomi così grossi da poter essere percepiti con i sensi. Gli atomi restano sempre quelli che sono: al contrario, gli aggregati corporei mutano in continuazione, avendo infinite possibilità di aggregazione. La formazione di un nuovo aggregato corporeo è ciò che chiamiamo nascita, mentre la disgregazione di tale aggregato è ciò che definiamo morte. Naturalmente, però, gli atomi non vanno perduti, ma tornano ad aggirarsi nello spazio in attesa di essere, per così dire, riciclati in una nuova aggregazione: per cui si può dire che, mentre i singoli aggregati hanno un'esistenza limitata nel tempo, la materia in sé è eterna (con un apparente paradosso, Lucrezio parlerà di mors immortalis, alludendo al fatto che gli atomi di cui siamo composti continueranno ad esistere dopo la nostra morte, indifferenti ad essa, essi sì immortali). Di qui la famosa formula che sintetizza il principio-chiave della fisica epicurea: "nulla nasce dal nulla; nulla ritorna nel nulla; tutto si trasforma". Il numero degli atomi è infinito, così come infinito è lo spazio vuoto (se non fosse infinito, da che cosa sarebbe delimitato?). E, poiché infinite sono pure le possibilità di aggregazione, infiniti sono i mondi possibili, ciascuno in sé destinato a perire: anche la Terra, perciò, non è che uno degli infiniti mondi possibili ed è destinata a morire, prima o poi. Non deve sfuggire la portata etica di questa affermazione: contro la presunzione che porta l'uomo a credere se stesso ed il suo pianeta al centro dell'universo, Epicuro afferma che l’uomo non è che uno degli infiniti aggregati di atomi possibili, così come lo è la Terra, e non esiste alcun progetto divino che lo voglia re del creato e lo autorizzi a ritenersi superiore alle altre forme viventi. E' evidente qui il rifiuto convinto e polemico, da parte di Epicuro, di ogni teleologismo (o finalismo): ciò che accade non accade per uno scopo prestabilito (da chi?), per cui non esiste il Destino ed è completamente irrazionale l'interpretazione che l'uomo dà di alcuni fenomeni naturali, come le malattie, il fulmine o il terremoto, quasi che essi accadessero allo scopo di punire l'uomo. Essi dipendono dall'incontro casuale e non necessario degli atomi, e non "significano" nulla. E tuttavia Epicuro non è ateo: egli crede, infatti, nell'esistenza degli dèi, appunto perché solo ciò che è reale è pensabile, e noi pensiamo gli dèi: essi dunque sono dotati di un'esistenza materiale, ma sono fatti di atomi leggeri e speciali e dispongono di un continuo "ricambio" di atomi, per cui sono immortali. La loro sede è negli spazi cosmici posti fra i vari mondi (gli intermundia lucreziani). Ad essi, in quanto immortali, perfetti e beati, va tributata la nostra venerazione, ma in modo del tutto disinteressato e gratuito: non certo allo scopo di ottenerne favori, come di solito fa l'uomo, la cui preghiera è quasi sempre mercenaria; pregare in questo modo non solo è moralmente spregevole, ma anche del tutto inutile, perché gli dèi si disinteressano completamente delle vicende cosmiche, e quindi anche di quelle umane: infatti la loro condizione di beatitudine non è compatibile con il turbamento che deriverebbe dall'occuparsi e preoccuparsi delle alterne vicende degli aggregati corporei. Quanto all'uomo, egli non è che uno dei tanti possibili aggregati di atomi: di atomi "pesanti" è fatto il suo corpo, di atomi "sottili" la sua anima, entrambi comunque destinati a dissolversi con la morte, come tutto il resto. Nulla resta di noi, come individui, dopo la morte: dissoltasi l'unità del complesso, gli atomi non conservano più alcuna sensazione di ciò che fu tale complesso. Al di là della nostra breve parentesi di vita, per noi è il nulla. L'anima pervade tutto il nostro corpo, costituendone la forza vitale, l'unità organica. Una parte di essa (quella che Lucrezio chiama animus, per distinguerla dal soffio vitale o anima) è in grado di pensare, per cui bisogna presupporre che sia costituita da atomi di natura davvero particolare, diversi da tutti gli altri. E' da questa definizione dell'anima che Epicuro prende le mosse per la sua teoria della conoscenza.
Logica (gnoseologia) Non esistendo nulla di alternativo alla materia, anche il sistema conoscitivo epicureo non può che essere materialistico. Si conosce, anzitutto, mediante la sensazione (àisthesis): essa è una modificazione, un'impressione in senso etimologico, cioè un'"impronta" (týpos) prodotta da un oggetto esterno sui nostri sensi. Escludendo che a produrre tale modificazione possa essere il vuoto, è evidente che ne sono responsabili gli atomi, che modificano gli atomi-occhio, gli atomi-orecchio, gli atomi-naso e così via. Tuttavia noi non abbiamo percezione diretta dei corpi: ciò che impressiona i nostri sensi sono gli èidola, i lucreziani simulacra che emanano dagli oggetti: calchi perfetti degli oggetti stessi, essi sono costituiti però da atomi sottilissimi e velocissimi (senza questa teoria non si spiega, ad esempio, il meccanismo della vista, che non comporta un contatto diretto con i corpi). E' essenziale notare, a questo proposito, come Epicuro si ponga in netta contrapposizione rispetto a Platone ed agli Stoici: la sensazione, egli afferma, è sempre vera proprio perché alogica: infatti, quando si commette un errore di valutazione, non è mai la sensazione che sbaglia, ma il giudizio che su di essa formula la ragione. Infatti, in caso di dubbio, è ancora e sempre dai sensi che viene la verifica definitiva (celebre l'esempio della torre: chi, da lontano, vede una torre quadrata e la giudica rotonda, non sbaglia per colpa della sensazione, ma per colpa dell'indebito intervento della ragione; costui potrà rendersi conto della effettiva forma della torre solo avvicinandosi ed osservandola meglio, cioè grazie ai sensi). Per Epicuro, dunque, conoscere significa essenzialmente "seguire le voci (fthòngoi) delle cose". Perfettamente coerente con questi presupposti è l'abbandono epicureo della dialettica e della retorica, che non sono di alcun aiuto per la comprensione dei fenomeni fisici. I problemi, per la logica epicurea, nascono allorché si tenta di spiegare, in base a questi princìpi, come avvenga la conoscenza dei fenomeni non evidenti (tà àdela) e come si realizzi il meccanismo del pensiero astratto. Anzitutto le impressioni sono di due tipi, o per meglio dire di due livelli: se si producono sui sensi si chiamano, appunto, "sensazioni" (es. l'impressione cane); se, attraverso i sensi, modificano anche gli atomi dell'anima, si chiamano "affetti" (es. l'impressione dolore). Grazie al ricordo, fondamento essenziale del pensiero umano (consistente in una duratura impressione prodotta dalle cose sugli atomi della mente), ed all'epiloghismòs (capacità di collegamento fra le impressioni), sensazioni ed affetti si connettono in rapporti reciproci e si configurano in immagini, alle quali la mente umana dà un nome, senza il quale le immagini stesse non potrebbero esistere: il nome legato all'immagine mentale costituisce quello che chiamiamo concetto o nozione, e che Epicuro definisce "prolessi" (pròlepsis), ossia "anticipazione". Questa definizione è dovuta al fatto che il concetto ci permette di prevedere, anticipare appunto, le caratteristiche generali di un oggetto che sia già caduto sotto i nostri sensi, anche senza averne esperienza immediata. Se così non fosse, non potremmo pensare, ad esempio, ad un cavallo che non abbiamo mai visto e che non stiamo vedendo. "Canoni" di ciò che chiamiamo vero sono appunto le sensazioni, gli "affetti" e le "prolessi", che sono sempre veri. Non sempre vera, invece, è l'opinione, che da essi deriva, ma che, esercitandosi su oggetti non ben conosciuti, può essere scorretta: essa, per Epicuro, è una "ipolessi" (hypòlepsis), cioè una semplice presunzione, che attende conferma dall'esperienza (si ripensi all'esempio della torre). Certo non è facile, in base a questi presupposti, spiegare che cosa sia, concretamente, nella mente umana, a formulare un giudizio errato (cioè quali atomi e perché commettano l'errore): Epicuro, nella Lettera ad Erodoto, parla di un non meglio identificato "moto che sorge in noi", parallelo, ma distinto, rispetto all'atto conoscitivo. Altrettanto poco chiaro è il meccanismo dell’epiloghismòs, che trasforma le percezioni in immagini mentali. Vero, dunque, è ciò che non risulta in contraddizione con l'esperienza, la quale si realizza attraverso sensazioni, affetti e prolessi. Riguardo agli àdela (le cose che non cadono sotto i sensi, e di cui perciò non possiamo avere esperienza), l'uomo non può procedere che per "induzione" o inferenza, cioè per intuito e per analogia rispetto ai fenomeni percepibili: del vuoto o spazio, ad esempio, noi non abbiamo percezione, ma non possiamo non pensare che esista, perché senza di esso non è pensabile il reale. Anche in questo caso, non è assolutamente facile comprendere come possa avvenire, mediante gli atomi della mente, questo processo di inferenza, che Epicuro definisce epibolè tès dianòias, un meccanismo attraverso il quale la mente "afferra" l'oggetto della conoscenza in modo intuitivo. Occorre inoltre osservare come il principio secondo cui un giudizio è vero fino a prova contraria sia in sé molto discutibile. I princìpi della logica vengono quindi a coincidere con i princìpi della fisica, nel senso che i princìpi che permettono di pensare rettamente il reale sono gli stessi che fondano la realtà fisica. Non è un caso che Epicuro, nella fisica, faccia appello alla massima esattezza terminologica possibile, in quanto espressione di esattezza logica: infatti, come si è detto, data l'impressione di una cosa, sempre vera, la mente ne elabora una rappresentazione (reale, perché fatta di atomi, e sempre vera), che si traduce immediatamente in un "nome" (anch'esso reale e fatto di atomi, ed anch'esso sempre vero). Tale nome è dunque la traduzione in suono dell'impressione: e, come l'impressione è alogica, così il nome è apofàntico, cioè derivante in modo spontaneo e immediato dall'impressione, esattamente come un'interiezione. Nell'annosa questione dell'origine del linguaggio (dalla phýsis o dal nòmos?), Epicuro si schiera dunque decisamente dalla parte di coloro che sostengono l'origine naturale del linguaggio, pur precisando che, con l'evoluzione storica delle varie civiltà anche le varie lingue si sono storicizzate e sono andate soggette, come tutto il resto, a convenzioni: il linguaggio umano è quindi, per così dire, naturalmente convenzionale.
Etica Il punto di partenza per l'indagine etica di Epicuro è, come sempre, l'osservazione empirica dei fenomeni naturali: bene e male non si possono definire in assoluto e in base a princìpi astratti, né possono essere ridotti a discorsi edificanti. Poiché infatti, per Epicuro, non esiste nulla se non la natura-materia (non si dimentichi che anche l'anima è materiale), è evidente che lo scopo dell'etica non può essere altro che il "vivere secondo natura", il che costituisce la felicità (eudaimonìa). Il criterio discriminante per riconoscere ciò che dà la felicità è rappresentato ancora una volta dalla sensazione: ogni sensazione piacevole è per natura gradita alla materia, e perciò è bene; ogni sensazione sgradevole, per converso, è naturalmente odiosa alla materia, e perciò è male. Semplificando e generalizzando, si può dunque affermare che bene è il piacere, male è il dolore, e che il piacere (hedonè) è il mezzo essenziale per la conquista del fine costituito dalla felicità, cioè la vita secondo natura. Finché però l'uomo permane in uno stato di ignoranza, non gli è possibile ottenere la felicità: infatti dall'ignoranza deriva la maggior parte delle false opinioni e dei turbamenti dell'animo umano, che impediscono di essere felici. L'uomo ignorante non sa che cosa sia in realtà il piacere, né da che cosa derivi: come può dunque essere felice? Fondamentale è per Epicuro la conquista di una comprensione razionale della realtà naturale (di cui l'uomo non è che una parte), che sola può liberare dalle false opinioni, fonte di inquietudine. Solo un saggio "calcolo" (loghismòs), un libero atto della volontà, cioè della razionalità, può portare alla conquista del vero piacere: ecco perché per Epicuro la saggezza (frònesis) è la virtù dalla quale provengono tutte le altre, "anche più apprezzabile della filosofia" (Lettera a Menèceo); e "l'essenziale per la felicità è la nostra condizione intima, di cui siamo padroni noi" (fr. 109 Bignone). Polemizzando indirettamente con la scuola cirenaica, che propagandava la ricerca del piacere tout court, Epicuro dà una definizione "scientifica" del dolore e del piacere che si allontana alquanto dall'opinione comune: ogni sensazione sgradevole è determinata dal movimento convulso e disarmonico degli atomi che costituiscono il corpo o l'anima, così come ogni sensazione piacevole deriva da uno stato di equilibrio e di armonia dei medesimi atomi. Non tutti i cosiddetti piaceri corrispondono a questa definizione: la maggior parte di essi, infatti, provoca un'agitazione degli atomi del corpo, che si ripercuote anche sugli atomi dell'anima, causando turbamento e finendo così per assomigliare al dolore. Per contro, alcuni tipi di dolore non alterano di molto lo stato di quiete degli atomi, e perciò non causano grave turbamento. Ne deriva che "tutti i piaceri [...] sono bene, ma non tutti sono da scegliersi, così come tutti i dolori sono male, ma non tutti sono tali da doversi fuggire" (Lettera a Menèceo). Sulla base di questi presupposti, Epicuro procede ad una classificazione sistematica dei vari tipi di piacere, operando due tipi di distinzione. La prima distinzione, basata sul comportamento degli atomi, divide i piaceri in due categorie: hedonè en kinèsei (= piacere in movimento);hedonè katastematikè (= piacere statico o in quiete). Il primo è ciò che si definisce comunemente piacere: esso consiste in un'agitazione convulsa degli atomi del corpo, che coinvolge però anche quelli dell'anima, causando un allontanamento dallo stato di quiete degli atomi stessi, ossia in definitiva un turbamento psico-fisico.Il secondo è anzitutto assenza di dolore (aponìa), fisico o psichico, uno stato di quiete e di serenità che non altera la disposizione naturale degli atomi. Fra i due tipi è senz'altro da preferire il secondo, in quanto, per così dire, privo di effetti collaterali spiacevoli. In questo ambito rientrano molti piaceri dell'anima (non tutti!), che Epicuro considera superiori a quelli del corpo, se non altro perché coprono un ambito più vasto. La seconda classificazione divide i piaceri in tre categorie: piaceri naturali e necessari; piaceri naturali e non necessari; piaceri non naturali e non necessari. I primi si identificano in sostanza con le necessità primarie (mangiare, bere, dormire...) e sono sempre da soddisfare, perché in caso contrario l’esistenza stessa ne sarebbe gravemente compromessa. I secondi comprendono quei piaceri che, pur risultando conformi agli istinti naturali, possono essere eliminati dall'esistenza senza che questa abbia a soffrirne: ad esempio, preferire cibi gustosi e raffinati e dormire comodamente è certo naturale, ma non è affatto necessario. In questa categoria rientra anche il sesso, che Epicuro non condanna, ma non considera necessario (salvo, evidentemente, per fini riproduttivi). I piaceri di questo tipo possono essere soddisfatti o meno, a seconda del temperamento individuale: ognuno, in questo ambito, deve essere giudice onesto di se stesso; se, ad esempio, un individuo non è in grado di dominare la gola, o i propri istinti sessuali, è meglio che si astenga da questi piaceri, perché essi sono destinati a creare in lui una forma di dipendenza: ciò significa che, il giorno in cui ne fosse privato, essi si trasformerebbero per lui in una fonte di sofferenza. I terzi sono quelli che l'uomo comune definisce piaceri, e che invece non sono altro che falsi bisogni, generalmente indotti dalle convenzioni sociali (nòmos): potere, ricchezza, prestigio sociale, lusso, bellezza, cultura e via discorrendo; fra questi vi è pure l'amore, che, inteso come passione travolgente (èros) o sovraccaricato di valenze ideali (si pensi a Platone), è prima di tutto una menzogna (esso, infatti, non ha di reale altro che la pulsione sessuale dalla quale nasce ed in funzione della quale esiste; è in sostanza una "strategia" della materia per perpetuare se stessa mediante la riproduzione: tutto il resto deriva dall’immaginazione dell'uomo) ed è totalmente negativo per l'individuo, che avvolge in una rete inestricabile di dipendenze. Ogni forma di dipendenza significa sofferenza, se non nel presente certamente nel futuro, allorché si venga privati della fonte della nostra illusoria felicità: e l'amore, da questo punto di vista, è uno dei falsi bisogni più insidiosi, come dimostra il senso di strazio che prova l'innamorato abbandonato e l’estrema difficoltà che avverte di ritornare ad una disposizione d'animo "normale". Questa sofferenza è la prova evidente che l’amore non è fonte di felicità: infatti la vera felicità non dipende mai da qualcosa di esterno, ma sempre e soltanto dalla nostra disposizione interiore. I piaceri di questa terza categoria sono da evitare, perché il turbamento che provocano è sempre superiore alla soddisfazione che danno; in altre parole, essi sono destinati, prima o poi, a trasformarsi in fonte di dolore. Come si può notare, si tratta di un'etica non soltanto rigorosa, ma quasi ascetica: il ritratto caricaturale degli epicurei che verrà fatto a Roma, ove essi saranno sistematicamente dipinti come gaudenti privi di ogni freno morale (si pensi alla polemica ciceroniana e all'ironica autodefinizione di Orazio come Epicuri de grege porcus), è dunque intenzionalmente deformante, e tradisce la volontà di mettere in cattiva luce la dottrina del Maestro per fini essenzialmente politici: come si vedrà, infatti, Epicuro pretende dai suoi seguaci il disimpegno politico, il che, per l'etica della classe dirigente romana, è semplicemente impensabile. La rigida autodisciplina che, sola, può consentire all'uomo di emanciparsi dalle dipendenze e di raggiungere la vera felicità, non è però completa senza il cosiddetto Tetrafàrmaco (= quadruplice medicina). Infatti, anche appurato in che cosa consiste il piacere, è evidente che l'uomo non può raggiungerlo finché è ostacolato dalla sofferenza, fisica o psichica. Secondo Epicuro, alla radice di tutte le sofferenze umane stanno quattro paure: paura del divino, paura della morte, paura del dolore, paura di non poter essere felici. Il Tetrafarmaco è infatti così articolato:
Il divino non deve fare paura perché, anzitutto, gli dèi non intervengono nelle vicende umane e non puniscono gli uomini, né in vita né dopo la morte. In secondo luogo, poiché l'anima non sopravvive al corpo, non potrebbe ricevere alcun castigo dopo la morte. La morte non deve fare paura perché non è dolore, perché dopo la morte, non essendoci nulla, non c'è nulla da temere, e perché, secondo una celeberrima definizione, non esiste per l'uomo: infatti, "quando ci siamo noi, non c'è la morte, e quando c'è la morte non ci siamo noi". Il dolore è forse il più temibile dei quattro elementi: ma esso, quando è troppo violento, annulla la coscienza; quando è meno violento, può essere sopportato grazie all'abitudine (Epicuro stesso fu di esempio in questo senso, sopportando con grande serenità la dolorosa malattia che lo condusse alla tomba). La paura di non essere felici è la più insidiosa ed irrazionale: infatti, anche una volta eliminati i primi tre tipi di paura, l'uomo non è ugualmente felice, perché è convinto di dover raggiungere determinati obiettivi sociali e culturali; in realtà, invece, per essere felice non ha bisogno di altro che di vivere secondo natura, seguendo i piaceri naturali e necessari e liberandosi di tutti i falsi bisogni indotti dalla cultura. E' dunque necessario uno sforzo della razionalità per arrivare a comprendere questo. In definitiva, suprema felicità è l'ataraxìa (= assenza di turbamento), alla quale è preliminare, come si è detto, l'aponìa. Essa non dev'essere confusa con l'apàtheia stoica: quest'ultima è infatti una sorta di assoluta indifferenza a tutte le aggressioni esterne, derivante dal perfetto dominio delle emozioni. Invece l'ataraxìa consiste nella ricerca di un'esistenza lontana da fonti di turbamento esterne, nella convinzione che l'uomo sia fondamentalmente incapace di restare indifferente ad esse.Di qui la celebre massima epicurea làthe biòsas (= "vivi nascosto", o meglio "vivi appartato"), che implica la necessità di condurre un'esistenza schiva, lontana dall'impegno politico e dagli affari economici, fonte di infiniti turbamenti. In questa sua esistenza appartata il saggio non sarà tuttavia né solo né privo di affetti, ma coltiverà quello che per Epicuro è il tipo di rapporto umano più perfetto: l'amicizia (philìa).
|